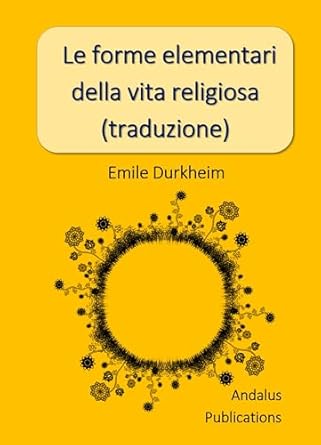Capitolo 2 - Il sacro come fondamento della società
Il sacro e l'ordine collettivo
Il sacro non riguarda soltanto l'individuo: fin dai primi gruppo organizzati, esso diventa strumento di coesione, di legittimazione, di continuità sociale. Le religioni arcaiche non separavano il culto dalla vita politica ed economica: erano il linguaggio con cui la comunità si narrava, si ordinava e trovava senso.
Rito e comunità
Il rito non è mai un atto marginale: costituisce il cuore della vita religiosa e delle comunità. Attraverso il rito, l'esperienza individuale viene ricondotta entro una cornice collettiva, e ciò che accade nella quotidianità viene innalzato a un piano simbolico. Come ricorda Victor Turner, il rito è uno spazio liminale, "tra e oltre", in cui l'individuo abbandona temporaneamente lo status ordinario per assumere un ruolo nuovo o per rigenerare il legame con la comunità.

Riti di passaggio: nascita, pubertà, matrimonio, morte. - Ogni fase fondamentale dell'esistenza viene accompagnata da pratiche rituali. Arnold van Gennep, che per primo ne studiò sistematicamente la struttura, mostrò come i riti di passaggio seguano uno schema tripartito;
- Separazione - l'individuo lascia lo stato precedente (es. l'adolescente che si separa dall'infanzia);
- Margine o liminalità - fase di sospensione, in cui il soggetto non appartiene né alla condizione passata né a quella futura.
- Aggregazione - rientro nella comunità con un nuovo status riconosciuto e legittimato.
Il rito, quindi, non è solo celebrazione, ma anche "macchina simbolica" che trasforma l'individuo e lo integra nel tessuto sociale.
Riti stagionali: non meno importanti sono i riti che scandiscono il tempo collettivo. Le feste legate ai cicli naturali - semina e raccolto, solstizi ed equinozi - non hanno soltanto funzione agricola: esse riattualizzano l'ordine cosmico e lo rendono presente nella vita della comunità. In queste celebrazioni, l'uomo non si limita a osservare i cicli naturali, ma vi partecipa, diventano co-creatore dell'armonia cosmica.
Il rito come ripresentazione
Ogni rito, come osservava Mircea Eliade, è ripetizione di un evento primordiale. Non si tratta di memoria nostalgica, ma di una vera e propria "riattualizzazione": nel rito, il mito delle origini torna vivo, e l' oggi viene riconnesso all'archetipo. In questo senso, il rito non è mai mera ripetizione: è una soglia che permette di attingere a un tempo sacro, qualitativamente diverso dal tempo profano.
Funzione sociale e antropologica
Il rito rafforza la memoria culturale: ciò che viene celebrato periodicamente si imprime nell'immaginario collettivo e diventa patrimonio identitario. Al tempo stesso, stabilisce regole di appartenenza: chi partecipa al rito è parte della comunità, chi ne è escluso resta ai margini. In questo senso,i riti non solo trasmettono credenze religiose, ma anche strutture di potere, codici morali, identità sociali.
Il mito come narrazione fondativa
Il mito non va inteso come una semplice favola o narrazione ingenua, ma come un racconto sacro che offre all'uomo e alla comunità un modello esemplare. Esso non si limita a intrattenere: ha la funzione di spiegare l'origine delle cose e di fondare l'ordine del mondo. Come sottolineava Mircea Eliade, il mito è sempre storia vera, perché parla di eventi avvenuti "in illo tempore", al principio, e la sua forza consiste proprio nel costruire un paradigma che può essere riattualizzato attraverso il rito.
Il mito svolge così:
- una funzione cosmologica, perché descrive la nascita del cosmo e il suo ordinamento;
- una funzione sociale, poiché legittima istituzioni, gerarchie e ruoli;
- e una funzione etica, in quanto propone modelli di comportamento e stabilisce ciò che è lecito o proibito.
Nelle civiltà arcaiche, ad esempio, il re non è soltanto un capo politico, ma una figura che trae legittimità dal mito delle origini: il suo potere è garantito dalla divinità o dalla cosmogonia narrata nei testi sacri. Allo stesso modo, i sacerdoti non esercitano un ruolo per semplice delega sociale, ma perché il mito assegna loro la funzione di mediatori tra il mondo umano e quello divino. Persino la comunità trova la propria coesione e identità nel racconto mitico, che spiega non solo come essa esiste, ma soprattutto perché.
In questo senso, il mito è fondazione e giustificazione: non racconta solo ciò che è accaduto, ma stabilisce ciò che deve essere. E' per questo che i miti sono accompagnati da riti: il rito rinnova periodicamente il mito, rendendo presente quell'ordine originario e riaffermando il posto di ciascuno all'interno del cosmo e della società. Così, mentre nella modernità la parola "mito" è spesso sinonimo di finzione o illusione, nelle culture antiche il mito è ciò che garantisce la verità più profonda: la verità dell'appartenenza, della continuità e del senso.
Sacro e potere politico
La connessione tra religione e potere politico non è un incidente della storia, ma una costante delle società umane. Fin dalle prime civiltà, l'autorità del sovrano si è nutrita di simboli e legittimazioni religiose: governare non significava soltanto amministrare la giustizia o garantire l'ordine militare, ma soprattutto incarnare un ordine cosmico. Il potere temporale, senza il sostegno del sacro, appariva fragile, destinato a crollare; con esso, invece, assumeva carattere di necessità e di eternità.
In Egitto, ad esempio, il faraone non era semplicemente un uomo al vertice della gerarchia: egli incarnava la Maat, l'ordine universale che regolava le stelle, le acque del Nilo e i rapporti sociali. La sua figura non era quindi soltanto politica, ma ontologica: senza di lui, il mondo avrebbe rischiato di ricadere nel caos primordiale. I rituali quotidiani celebrati nei templi non erano "omaggi religiosi" in senso moderno, bensì atti indispensabili per mantenere il cosmo in equilibrio.
Il tempio non era solo luogo di culto, ma anche centro economico, politico e amministrativo. Custodiva terre, gestiva raccolti, garantiva scambi e redistribuzioni.
Nella Mesopotamia, i templi delle grandi città-stato non solo ospitavano le statue divine, ma funzionavano da veri e propri centri di potere, controllando le risorse agricole e legittimando le decisioni dei sovrani. Il sacerdote e il re agivano insieme come garanti di un ordine che univa il cielo e la terra.
A Roma, la sacralizzazione del potere raggiunse una forma sofistificata: l'imperatore riceveva culto come divinità vivente, soprattutto in Oriente. Non era un capriccio o un eccesso di adulazione, ma un modo per garantire coesione all'immenso impero. Adorare l'imperatore significava riconoscere nell'ordine politico romano un riflesso dell'ordine cosmico, e dunque un vincolo sacro che univa popoli, lingue e culture differenti.
In tutte queste forme, ciò che emerge è la funzione sociale del sacro: legittimare il potere e trasformarlo in istituzione necessaria, sottraendolo alla contingenza. Un re che governa in nome degli dei non è soltanto un uomo: è un mediatore, un ponte tra visibile e invisibile. Così la comunità, riconoscendosi in questa visione, trova stabilità e continuità.
Il sacro come collante sociale
Emile Durkheim, nella sua celebre opera Le forme elementari della vita religiosa (1912), sostiene che il sacro non sia un fatto individuale, ma un'esperienza eminentemente sociale. Quando un gruppo umano separa certi oggetti, gesti o parole e li dichiara "sacri", esso non sta semplicemente attribuendo loro un valore simbolico: sta creando un confine identitario che distingue ciò che appartiene alla comunità da ciò che ne resta fuori. In questo senso, il sacro non riguarda tanto gli dèi o le divinità in se, quanto la forza del collettivo che li istituisce.
La distinzione tra sacro e profano è il nucleo del pensiero durkheimiano:
- il profano comprende le attività quotidiane, ordinarie, legate alla sopravvivenza e alla routine;
- Il sacro, al contrario, appartiene a una sfera separata, inviolabile, che richiede rispetto e tabù.
Questa separazione non nasce da una rivelazione individuale, ma dal consenso collettivo. E' la società stessa la propria energia e vitalità sul simbolo sacro, rendendolo depositario della sua unità.
Il sacro diventa allora un collante, capace di tenere insieme i membri della comunità:
- i riti servono a rinnovare periodicamente questa coesione;
- i simboli condensano in un'immagine l'identità del gruppo;
- le credenze condivise offrono un orizzonte di senso comune.
E' ciò che Durkheim chiama "effervescenza collettiva": nei momenti rituali, la comunità sperimenta un'intensità emotiva che supera la somma delle singole individualità, generando un senso di appartenenza e di trascendenza.
Anche le società secolarizzate, prive di religioni dominanti, non possono eliminare il sacro: lo trasformano. Ecco perché Durkheim parlava di religione civile: simboli come la bandiera, la Costituzione, la memoria dei caduti in guerra o riti collettivi come celebrazioni nazionali, giuramenti e commemorazioni assumono una funzione quasi liturgica. Non sono "religioni" nel senso tradizionale, ma esercitano lo stesso ruolo: definire ciò che è inviolabile, ciò per cui si è disposti a sacrificarsi, ciò che fonda l'identità collettiva.
In questa prospettiva, il sacro non è un retaggio del passato, ma una dimensione antropologica che riemerge in forme nuove. Oggi possiamo riconoscerlo non solo nei simboli religiosi, ma anche nelle passioni politiche, nello sport, nelle icone culturali o nei valori universali proclamati dall'umanità. Laddove una comunità si stringe attorno a un simbolo, generando rispetto, tabù e senso di appartenenza, lì opera la dinamica del sacro descritta da Durkheim.