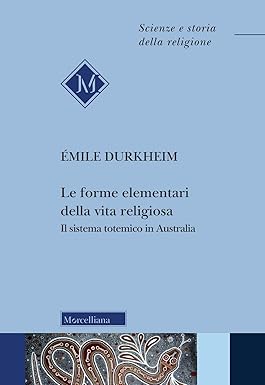Capitolo 4 - Le immagini del divino: trasformazioni e simboli
L'uomo non ha mai concepito il divino come pura astrazione. Anche quando lo ha pensato come principio ineffabile o assoluto, ha sentito il bisogno di rappresentarlo: di dargli forma, volto, gesto, voce. In ogni cultura, il divino si manifesta attraverso immagini, miti e simboli - non come semplici ornamenti della fede, ma come mediazioni necessarie tra il visibile e l'invisibile.
La mente umana, nel tentativo di dire ciò che è al di la delle parole, produce figure, racconti e archetipi che traducono l'infinito nel linguaggio del finito. Come scriveva Ernst Cassirer, l'uomo è un animal symbolicum: non vive nel mondo delle cose, ma in quello dei significati. Il simbolo non è un segno arbitrario, bensì un ponte, "un mondo in cui il reale si apre al suo oltre".
Per le società tradizionali, il mito non è "favola" né "invenzione poetica", ma storia sacra. Racconta un tempo originario - in illo tempore - in cui gli dei, gli antenati o le potenze cosmiche fondano il mondo. Il mito è dunque rivelazione e modello: dice come le cose sono venute all'essere e come essere mantenute.
Come ha mostrato Mircea Eliade, attraverso il mito l'uomo arcaico si collega al tempo primordiale, rinnovando nel rito quella prima creazione. Narrare o rivivere il mito significa "riattualizzare il sacro", riportare la vita quotidiana al suo principio ordinatore. Ogni gesto rituale, ogni simbolo, ripete un gesto divino: è imitazione (mimesis) e partecipazione.
Nella prospettiva junghiana, il simbolo religioso è la manifestazione dell'archetipo: una forma universale dell'inconscio collettivo che trova espressione nelle diverse culture. L'immagine del Sole, del Mare, della Madre, del Viaggio o della Montagna non è solo poetica: è una figura psichica che traduce l'esperienza del mistero.
Per Jung, l'archetipo è ambivalente: è insieme struttura psichica e presenza numinosa, ciò che egli chiamava "numinoso" riprendendo Rudolf Otto. Quando il simbolo appare - in un sogno, in un rito, in un'immagine sacra - non è il prodotto della fantasia individuale, ma un evento psichico oggettivo, una forma in cui l'inconscio collettivo si manifesta.
Simbolo e immaginazione: un linguaggio del sacro
Il simbolo religioso non è quindi un segno da decifrare razionalmente, ma una presenza che agisce. In ogni tempo, le immagini sacre funzionano come porte del senso: finestre attraverso cui l'uomo percepisce l'oltre. L'immaginazione, come suggeriva Gilbert Durand, non è evasione o illusione, ma una facoltà conoscitiva autonoma, capace di articolare l'esperienza del sacro in forme visive, narrative e rituali.
James Hillman ha ripreso questa intuizione parlando di una psicologia dell'immaginazione: non si tratta di "spiegare" i simboli, ma di ascoltarli, di lasciarli parlare. Ogni immagine religiosa è una psicofania: un'apparizione dell'anima collettiva dell'umanità.
In questa luce, le immagini divine - dal toro celeste mesopotamico alla Vergine cristiana, da Shiva danzante al Bodhisatta della compassione - non sono proiezioni antropomorfe, ma rivelazioni di un ordine profondo. Esse "rappresentano" il divino nel senso etimologico del termine: lo rendono presente di nuovo (re-presentare).
Il simbolo è quindi performativo: non indica, ma fa essere. Incontrarlo significa partecipare. Quando l'uomo contempla un'immagine sacra o ascolta un mito fondatore, non si limita a ricevere informazioni, vive un evento di presenza, un contatto con ciò che sfugge alla misura del pensiero.
Ogni rappresentazione del divino custodisce un paradosso: cerca di fare forma a ciò che, per definizione, non ha forma. Ma proprio in questa tensione tra limite e infinito nasce il linguaggio religioso. Il simbolo non annulla il mistero, lo mantiene vivo, ricordando che il sacro non può essere posseduto né detto una volta per tutte.
Come scriveva Paul Ricoeur, il simbolo "dà a pensare": apre lo spirito, lo costringe a interrogarsi. In questo senso, l'intera storia del pensiero religioso può essere letta come una storia dei simboli, della loro nascita, delle loro metamorfosi e del loro potere di tenere unito il visibile e l'invisibile.
Il sacro come presenza diffusa
Nelle società più antiche, l'esperienza del sacro non è separata dal mondo. Non esiste ancora una distinzione netta tra natura e soprannatura: l'intero universo è percepito come animato, permeato da una forza vitale che attraversa ogni cosa. Montagne, fiumi, alberi, pietre, vento e fuoco non sono "oggetti", ma soggetti dotati di volontà, potere e intenzione.
In questa prospettiva, la divinità è diffusa - non concentrata in una figura antropomorfa, ma presente ovunque. Come scrive Mircea Eliade, "per l'uomo arcaico il mondo è sempre più di ciò che appare: ogni cosa visibile rinvia a un invisibile che la fonda". Il sacro non è un luogo separato, ma la dimensione profonda della realtà stessa.
L'animismo: la vita come principio universale
Il termine animismo, introdotto da Edward B. Tylor nel suo classico Primitive Culture (1871), descrive la credenza secondo cui ogni essere naturale è animato da uno spirito o da un'anima (anima, spiritus). Questa non è filosofia "primitiva" nel senso ingenuo del termine, ma un modo complesso di esperire il mondo: un ontologismo relazionale, dove la realtà è costituita da interazioni tra soggetti dotati di interiorità.
L'animismo è, in effetti, una forma di ecologia spirituale ante litteram. L'uomo non si pone come dominatore, ma come interlocutore del mondo naturale. Il cacciatore chiede perdono all'animale ucciso, il contadino onora la terra prima di seminare, il viaggiatore parla alle acque prima di attraversarle. Ogni gesto umano è un atto di comunicazione con potenze viventi.
Il totemismo: identità e parentela cosmica
Accanto all'animismo si sviluppa il totemismo, studiato da Emile Durkheim e successivamente da Claude Levi-Strauss. il totem - spesso un animale, una pianta o un elemento naturale - rappresenta l'antenato mitico di un clan. Ma più che un simbolo figurativo, esso è un principio di identità: un legame di parentela tra l'uomo e il mondo non umano.
Durheim, nel suo "Le forme elementari della vita religiosa" (1912), interpreta il totemismo come la prima forma di religione collettiva: l'adorazione del totem è, in realtà, l'adorazione della società stessa, proiettata su un emblema naturale. Per Levi-Strauss, invece, il totemismo è un sistema di classificazione simbolica che organizza le relazioni tra gruppi umani e specie naturali: una logica del vivente che riflette la struttura mentale di chi vi partecipa.
In entrambi i casi, il totemismo mostra che l'umanità arcaica non si concepisce isolata dal mondo, ma come parte di una rete cosmica di affinità.
La natura come ierofania
Per l'uomo delle origini, ogni elemento naturale può diventare una ierofania - una manifestazione del sacro. La montagna, per la sua verticalità, appare come un asse che unisce terra e cielo; l'albero, che affonda le radici nel suolo e tende al sole, è simbolo di vita e di mediazione; il fiume, che scorre e rinnova, rappresenta il tempo e la continuità dell'esistenza.
Queste immagini non sono semplici metafore, ma modi di abitare il mondo. L'uomo arcaico non "pensa" il sacro come noi lo pensiamo: lo vive come esperienza concreta, come incontro con la potenza vitale delle cose. In ogni fenomeno naturale si manifesta un "di più" di senso: un'energia che suscita rispetto, timore, gratitudine.
Il volto del sacro nella vita quotidiana
Questa visione ha conseguenze profonde sull'etica e sull'organizzazione sociale. Se tutto è vivo, tutto merita rispetto. L'animale sacrificato, il fuoco acceso, l'albero abbattuto non sono risorse, ma relazioni sacre. La reciprocità diventa il principio fondante dell'esistenza: dare, ricevere, restituire.
Il sacro, dunque, non è un'entità astratta o lontana; è immanente, intrecciato alla trama della vita. L'uomo arcaico non ha bisogno di cercare Dio altrove - lo incontra nel tuono, nella nascita di un animale, nel ciclo delle stagioni, nella morte e nella rinascita della natura.
Dalla cosmoteandria all'antropomorfismo
Solo in un secondo momento, con l'emergere delle prime civiltà urbane e delle religioni organizzate, il sacro si antropomorfizza. Gli dèi assumono forma umana, si stabiliscono in templi, e la divinità diventa progressivamente trascendente rispetto alla natura. Ma l'eredità animistica e totemica rimane: sotto le immagini degli dèi antropomorfi, sopravvive la memoria di un mondo in cui ogni cosa era divina.
La nascita delle Grandi Madri e la trasformazione del sacro nel Neolitico
Con il Neolitico (circa 10.000-4.000 a.C.) si verifica una delle trasformazioni più profonde della storia umana: il passaggio da società di cacciatori-raccoglitori a comunità agricole e stanziali. Questa "rivoluzione agricola" non è solo economica o tecnologica: è una rivoluzione spirituale. L'uomo, che prima viveva immerso nel ritmo selvaggio della natura, diviene ora custode e artefice della fecondità della terra. Coltivare significa partecipare al mistero della generazione, ma anche affrontarne il lato oscuro: la necessità della morte come condizione della rinascita.
In questa nuova economia del sacro, la terra assume un ruolo centrale. E' grembo che nutre e accoglie, ma anche tomba che riassorbe. Da questa duplicità nasce una delle immagini più potenti e universali della spiritualità umana: la Grande Madre.
La Grande Madre: archetipo della totalità vivente
Le prime rappresentazioni di figure femminili risalgono già al Paleolitico superiore, ma è nel Neolitico che il culto della dea assume una diffusione sistematica e simbolica. Le celebri Veneri -come la Venere di Willendorf, la Venere di Lespugue, o la Venere di Laussel - rivelano una sensibilità orientata alla fertilità, alla ciclicità naturale e alla potenza generativa.



Queste statuette non rappresentano un ideale estetico nel senso moderno, ma un principio cosmico. I tratti anatomici accentuati - seni, ventre, fianchi - non sono erotici, bensì ieratici: esprimo, cioè, la forza della vita che si rinnova incessantemente.
Secondo Marija Gimbutas, che ha dedicato studi fondamentali al simbolismo neolitico europeo (The Language of the Goddess, 1989), la Grande Madre incarnava un sistema di valori centrato sull'armonia, la fertilità e il ciclo vitale. Le culture dell' "antica Europa", prima delle invasioni indoeuropee, avrebbero posseduto un linguaggio simbolico matrifocale, in cui la divinità femminile era metafora dell'unità tra natura, vita e morte.
La maternità cosmica
Il principio femminile non è qui semplicemente biologico, ma cosmico. La Dea è la Madre-Terra che partorisce il mondo e al tempo stesso lo accoglie di nuovo nel suo grembo. Nelle culture agrarie, il seme deposto nella terra diventa immagine del ritorno alla vita attraverso la morte: la semina e la decomposizione coincidono, il gesto agricolo è rito di resurrezione.
Come scrive Mircea Eliade, "l'aratura e la semina ripetono il gesto primordiale della creazione: l'uomo coopera con la Madre, con la Natura divine, nel perpetuare la vita".
L'agricoltura diviene dunque atto sacro: lavorare la terra è partecipare a un mistero cosmico in cui la nascita e la dissoluzione sono due volti della stessa potenza.
Questa concezione trova riscontro in moltissime tradizioni:
- la dea Inanna-Ishtar in Mesopotamia, signora della fertilità e della guerra, morte e rinascita.
- Demetra e Persefone nel mondo greco, simbolo del ciclo stagionale e del ritorno dal mondo dei morti.
- Iside in Egitto, madre e sposa, che ricompone il corpo smembrato di Osiride.
- Anat, Asherah e Astarte nel Levante, che uniscono eros e distruzione in un'unica forza vitale.
Morte e rinascita: il ciclo come metafisica
La Grande Madre non è soltanto generatrice: è anche distruttrice, custode del mistero del ritorno. L'archetipo contiene in se una dialettica di vita e morte, poiché ciò che nasce deve morire per poter rinascere. Nel Neolitico, questo principio diventa visibile nelle pratiche rituali legate alla sepoltura e alla fertilità. Le tombe, spesso scavate nel terreno o costruite a forma di ventre, riproducono simbolicamente il grembo della Madre: morire significa tornare nel suo corpo, per essere rigenerati.
Il tempo non è lineare ma circolare. La morte non è fine, ma fase di un ritmo cosmico eterno. Da questa visione nascono i primi miti agrari, le feste stagionali e i riti di rinnovamento che segneranno tutta la storia religiosa successiva.
Il declino del principio materno
Con l'avvento delle società patriarcali e guerriere del tardo Neolitico e dell'Età del Bronzo, la figura della Grande Madre subisca una trasformazione. Le divinità femminili vengono progressivamente integrate o subordinate a pantheon dominati da dèi maschi del cielo, del fulmine, della legge e della guerra. Tuttavia, il principio materno non scompare: si trasfigura. Riemerge in forme sincretiche e simboliche:
- come dea della saggezza (Atena), che custodisce l'intelligenza creativa;
- come Vergine Madre nelle religioni mediterranee e poi nel cristianesimo, dove Maria conserva la funzione di mediatrice cosmica;
- come Terra Mater nelle rappresentazioni popolari, nel folklore, e nei culti locali.
La Madre, dunque, non viene mai del tutto soppiantata: continua a operare come archetipo sotterraneo, come principio di coesione e di cura all'interno delle strutture patriarcali.
Significato antropologico e spirituale
La nascita della Grande Madre segna un passaggio di coscienza: l'uomo riconosce nella natura non solo la forza che lo nutre, ma anche il mistero che lo trascende e lo riassorbe. L'esperienza del sacro si interiorizza e si universalizza. La divinità non è più soltanto potenza esterna (come il tuono o l'animale sacro), ma presenza ciclica e immanente che accompagna ogni forma di vita.
In questo senso, il culto della Madre non è solo una tappa della religiosità antica, ma una matrice originaria dell'immaginario umano: la consapevolezza che vita, morte e rinascita non sono eventi distinti, ma espressioni di un'unica realtà vivente.
Dal cosmico all'umano: la forma antropomorfa del divino
Con la nascita delle prime città e dei primi stati, attorno ai IV millennio a.C, il sacro subisce una trasformazione strutturale. L'ordine religioso inizia a rispecchiare l'ordine politico. Il mondo non è più percepito solo come un intreccio di forze diffuse - spiriti, potenze della natura, energie cicliche - ma come un cosmo gerarchico, governato da divinità dotate di personalità, potere e volontà.
Il divino assume allora un volto umano. Non per semplice proiezione antropocentrica, ma per una semplice parte della natura, riconosce nel divino la propria stessa condizione, riflessa e sublimata. Il corpo, il linguaggio, le passioni diventano strumenti di mediazione con il trascendente.
Come scrive Jean-Pierre Vernant, l'antropomorfismo greco non è un abbassamento del divino, ma un innalzamento dell'umano: "gli dei assumono forma umana perché l'uomo è ormai misura e immagine del cosmo ordinato".
I pantheon come specchi dell'ordine politico e cosmico
In Mesopotamia, in Egitto, in Grecia - e più tardi a Roma - le divinità si organizzano in pantheon, cioè in sistemi teologici coerenti che riflettono la struttura sociale.
- In Mesopotamia, il cosmo è governato da una gerarchia divina che riproduce la città-stato: Anu regna nei cieli come il sovrano supremo, Enlil dirige gli affari terrestri, Ea/Enki presiede alle acque sotterranee e alla sapienza. Gli dèi, come i funzionari reali, hanno competenze e territori: il tempio è la loro "casa" e il sacrificio è il tributo dovuto alla loro sovranità.
- In Egitto, la regalità divina si lega all'ordine cosmico, il Maat, principio di equilibrio e giustizia universale. Il faraone è il mediatore tra uomini e dèi: partecipa della loro natura e garantisce l'armonia del tutto. Il pantheon egizio - con Ra, Osiride, Iside, Horus e Anubi - è una drammaturgia teologica in cui la nascita, la morte e la resurrezione del dio riflettono i cicli della natura e dell'anima.
- In Grecia, la religione olimpica traduce in linguaggio simbolico la polis. Zeus, come sovrano e giudice, Hera come custode della famiglia, Atena come ragione strategica, Afrodite come potenza del desiderio, Apollo come misura e armonia, Dioniso come disordine e rinnovamento. Il pantheon è un teatro dell'anima: ogni dio incarna una dimensione della psiche umana e del cosmo.
In tutte queste civiltà, gli dèi non sono entità lontane, ma immagini dell'ordine universale e sociale, figure archetipiche che rendono visibile la struttura del mondo.
L'antropomorfismo come archetipo spirituale
Gli dèi antropomorfi non sono semplici proiezioni delle passioni umane - come avrebbe sostenuto la critica illuminista o positivista (es. Fauerbach) - ma simboli viventi di funzioni psichiche e cosmiche.
Nella prospettiva junghiana, ciascun dio rappresenta un archetipo: un principio eterno dell'inconscio collettivo che struttura l'esperienza umana.
Zeus non è solo il padre autoritario, ma l'immagine della legge interiore, del potere ordinatore. Iside non è solo la madre, ma la matrice di senso che raccoglie e ricompone ciò che è disperso. Atena non è solo la dea della guerra giusta, ma l'intelligenza strategica della mente che trasforma la forza in sapienza. Apollo e Dioniso, infine, rappresentano i poli complementari della coscienza: il principio apollineo dell'armonia e quello dionisiaco della dissoluzione estatica.
Attraverso queste figure, le civiltà antiche elaborano una mappa del sacro che è anche una mappa dell'anima. L'uomo, riconoscendosi negli dèi, riconosce se stesso come partecipe del divino.
Dèi, città e destino
La religione delle città antiche non è solo culto, ma struttura simbolica dell'ordine sociale. Ogni tempio è al tempo stesso centro politico, economico e cosmico: custodisce il dio tutelare, il cui favore garantisce la prosperità della comunità.
Il rapporto con il divino diventa così contrattuale: l'uomo offre sacrifici, preghiere, riti di purificazione in cambio di protezione e fecondità.
La funzione conoscitiva del mito antropomorfo
Il mito, lungi dall'essere un racconto ingenuo, è uno strumento di conoscenza. Attraverso il linguaggio figurato degli dèi, l'uomo antico esplora i limiti e le potenzialità della propria condizione. Gli amori e i conflitti degli déi sono allegorie della coscienza: insegnano a riconoscere le forze che abitano l'interiorità e il mondo. Per questo, come scriveva Paul Ricoeur, il mito è un pensiero in immagini: non spiega, ma mostra; non dimostra, ma rivela. L'antromorfismo diventa così una forma di teologia umanistica: la via attraverso cui l'uomo impara che il divino non è altrove, ma in ciò che egli stesso può diventare.
La nascita dell'Uno: dal cosmo al Logos
Con l'avvento delle religioni monoteistiche, tra il secondo e il primo millennio a.C., l'umanità compie un salto di coscienza religiosa. Dopo millenni di rappresentazioni plurali del sacro - dèi, spiriti, forze cosmiche, archetipi - emerge un nuovo paradigma: l'unità trascendente del divino.
Il Dio unico non è più una potenza tra le altre, ma il fondamento assoluto dell'essere. Egli non appartiene al mondo, ma lo crea e lo sostiene. Il rapporto con il sacro non è più immediato, mediato da immagini naturali o antropomorfe: diventa relazione etica e dialogica. L'umanità non contempla più il mistero nella natura o nel mito, ma lo ascolta nella Parola. Il centro della religiosità si sposta dall'immagine alla rivelazione.
L'ebraismo: il Dio dell'alleanza e del Nome
Nella tradizione ebraica, l'idea di Dio si articola come trascendenza radicale.
YHWH non può essere rappresentato: "Non ti farai immagine alcuna di ciò che è in cielo, né di ciò che è sulla terra." (Es. 20,4).
Questo divieto non è semplice iconoclastia, ma una teologia della disstanza; Dio non appartiene al mondo delle forme, perché è altro rispetto a ogni cosa creata.